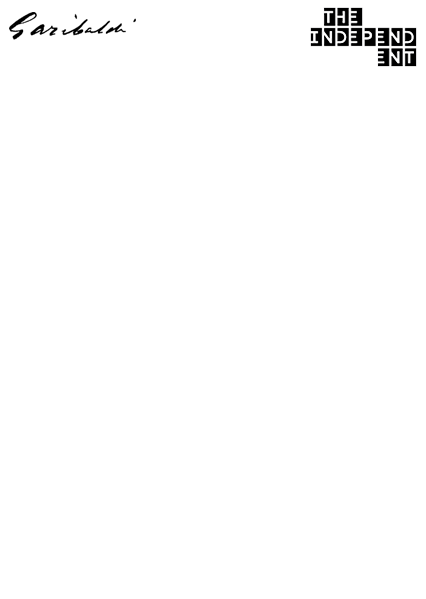
Anita Garibaldi
Caterina Riva
Nei tre anni in cui ho vissuto e lavorato in Nuova Zelanda, pensavo all’Europa con nostalgia e in maniera romantica: come fosse un baluardo della cultura e della storia. Ora che sono tornata nel mio continente di provenienza mi rendo conto che condizioni molto più meschine e sensazioni molto più terra a terra governano le politiche di queste latitudini. Rientrare è stato davvero complicato, provare a lavorare in Italia per una donna che ha superato i trenta si è presto rivelato un campo minato. Parto dal presupposto di avere le stesse capacità di un uomo quindi non mi pongo il problema di stare al mio posto perché ho letto, studiato e viaggiato troppo per accettare alcuna modalità sessista. Quando in Italia ho provato a ribellarmi il mio non allineamento è stato annacquato con frasi tipo “si vede che sei stata all’estero”.In effetti, ho studiato e vissuto a Londra a tra il 2006 e il 2011, di questi tempi, dopo il Brexit, ripenso a quanto fondamentale sia stato quel periodo e quanto diversa sarei stata se quella esperienza mi fosse stata preclusa. Sono cresciuta nel profondo Nord italiano quindi ne so qualcosa di chiusura e campanilismo, di luoghi fertili per la Lega Nord; nel mio caso proprio sul confine con la Svizzera, il Ticino dei frontalieri e della benzina che costa meno al di là del valico. La caserma della Guardia di Finanza che era nel paese dove abitano i miei genitori, vuota da anni, dopo aver favorito diverse storie d’amore tra ragazze del luogo e finanzieri in trasferta, ora ospita decine di immigrati che vengono da diverse parti dell’Africa, tutti uomini, ma di età, lingua, religione diverse.
Nel giardino della casa dove è cresciuta mia madre, ora parzialmente sommerso da un cespuglio di bosso c’è un busto di Garibaldi. Credo che mia madre e le sue sorelle si divertissero a baciarlo e a giocarci da bambine. Io lo ricordo imponente ma guardandolo ora da vicino mi accorgo che le proporzioni sono ridotte e che fa impressione solo se si è piccoli.
Ci sono frontiere e frontiere. Per diversi mesi a cavallo tra il 2015 e il 2016 mia madre si è dovuta sottoporre a chemioterapia. Vivere lo stigma del cancro da vicino è stata una dura prova. Per i cari è un po’ come portare a loro volta le cellule malate, senza sintomi ma con molta condivisione psicologica. Le persone per dimostrarmi la loro vicinanza di solito elencavano sintomi e rimedi vissuti da loro famigliari, conoscenti o da loro stessi.
L’indipendenza, se la intendiamo come lavoro freelance, per me non è tanto una scelta quanto l’opzione B se ci si vuole guadagnare da vivere. Vorrei tanto che il mio lavoro di curatrice in Italia sia rispettato e protetto, che se ne possa garantire una continuità, che la tassazione sia differente e tenga conto delle diverse condizioni di guadagno, come succede ad esempio in Francia con les intermittents du spectacle. Forse indipendente è diventata un’etichetta da reparto marketing e comunicazione per celare poco budget e un rapporto più informale con i soggetti invitati. Nel 2016 ho organizzato insieme a Dallas il progetto RIVIERA, una libreria funzionante con un fitto programma di eventi tra arte, editoria e design che ha occupato per quattro mesi la sede di Milano dell’Istituto Svizzero. La sfida era di offrire contenuti trasversali a pubblici diversi e creare un’abitudine alla frequentazione. Dal punto di vista organizzativo richiedeva sforzi di coordinamento oltre che il dover rispettare un budget stringato per le ambizioni del progetto. RIVIERA mi ha permesso di lavorare in maniera atipica con artisti e di immaginare con loro eventi di una serata con un confronto diretto con il pubblico e con le sue reazioni.
A fine agosto 2016 sono andata a Marsiglia, mesi prima l’artista Benjamin Valenza, mi aveva invitata a pensare ad un programma di video da inserire all’interno del progetto LABOR ZERO LABOR, una piattaforma di live streaming su un canale internet dedicato. LZL consiste nel mettere immediatamente in circolo delle opere concepite e realizzate per la videocamera; la diretta si propaga da uno spazio culturale ex industriale (La Friche) utilizzato come studio di produzione con set para-televisivi. Gli indipendenti si assumono più rischi: Benjamin Valenza fa il Mangiafuoco della situazione, lavora sempre con un gruppo di collaboratori fidati, una famiglia composta principalmente dai suoi attuali e vecchi studenti, che lo aiutano in ogni aspetto di gestione: la tecnica, dalle luci alle riprese, alla messa in linea. L’intenzione è quella di mantenere un ordine fluido dove ciascuno è simultaneamente operaio, attore e produttore, ideatore e manovale. Il progetto è mobile e si può ogni volta appoggiare a differenti realtà istituzionali.
A La Friche c’era una bella energia, forse un po’ di adrenalina dalla diretta che rende possibili cose impossibili e aggiunge umanità grazie a una dimensione più amatoriale che professionale. Il mezzo permette una diffusione che supera le barriere geografiche, seppur ribadendo le differenze di fuso orario. Le lingue, gli artisti, gli stili si mescolano e riflettono anche sul come questo materiale ci arriva – mediato o immediato – sul nostro portatile.
A volte compare l’odioso cerchio che gira, altre volte il contenuto viene bloccato per questioni di copyright, insomma gli stessi problemi del vagabondaggio e della ricerca online, globale ma anche limitata, si riproducono. LABOR ZERO LABOR invita i partecipanti a fidarsi e abbandonarsi a questa entità sospesa, un po’ terra pirata. Il progetto promette di testare tempistiche più sdrucciolevoli di quelle impiegate da una mostra e permette di lasciare i parametri ben conosciuti del white cube a favore delle numerose possibilità offerte dal green screen. La paura di sbagliare e la possibilità di fallimento sono minacce concrete ma sono anche la molla che spinge ad andare al di là delle proprie sicurezze e dei territori testati in cerca di nuovi spazi di condivisione: transazionali, transgenerazionali, transdisciplinari, trans.






