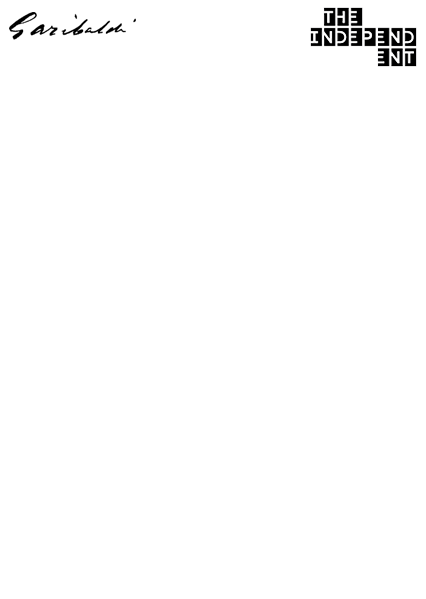Ideale autogestione. Gruppi di artisti negli anni settanta
Alessandra Pioselli
La parola indipendenza non ha una peculiare diffusione nel lessico dei collettivi e dei gruppi di artisti nel passaggio tra gli anni sessanta e settanta. Mutuata dalla politica militante, autogestione è la parola d’ordine perché definisce quelle forme di organizzazione cooperativistica del lavoro che esprimono il cosiddetto rifiuto della delega. «Così facendo [gli artisti] non perseguono altro che la progressiva riappropriazione del proprio ruolo di liberi ricercatori che aspirino a dialogare con gli altri uomini, possibilmente senza dover superare schemi frapposti o troppo deformanti», afferma Carlo Cioni nel catalogo della 1° Rassegna dei gruppi autogestiti in Italia[1]. Quando esce nel 1980, l’autogestione affossa nella sabbia del mutamento sociopolitico che renderà il termine anacronistico ma nel clima post Sessantotto lo sviluppo dei collettivi è stimolato da una cultura politica che vede «in generale l’esaltazione del modello democratico partecipativo»[2]. Per gli artisti l’autogestione è manifesto dell’autodeterminazione dei processi di produzione e distribuzione del lavoro ma costituisce pure il set per instaurare con gli altri (artisti e persone) «un rapporto umano non competitivo[3]. Nelle esperienze dei gruppi formatisi nei tardi anni sessanta emergono sollecitazioni distinte nell’uso sperimentale degli audiovisivi, nel recupero di matrici situazioniste e Fluxus, nell’aderenza alle tendenze dell’arte cinetica e programmata. Autori che contribuiscono allo sviluppo dell’Arte programmata considerano l’opera d’arte un modello per esplorare modi di conoscenza che avrebbero dovuto riverberare in altri ambiti della società, dall’industria alla comunicazione, all’educazione, allo spazio della città, formulando ipotesi che piegano talvolta verso un discorso più specificatamente urbano e politico. È la posizione di Davide Boriani. L’attività dell’Operativo ti.zero costituisce un altro caso. Altri gruppi portatori di altre estetiche trovano coesione nel rispondere a domande sociali, come a Milano il Collettivo autonomo di Porta Ticinese, il Collettivo Lavoro Uno o il Laboratorio di Comunicazione Militante. Queste formazioni confidano nell’autogestione per incorporare tale domanda nel progetto, condividendo con le altre esperienze la necessità di «definire un nuovo modo di operare», «innescare opere e esperienze aperte», «superare l’univocità del rapporto operatore-fruitore»[4]. La fisionomia dell’autogestione è generalmente estroflessa ma può essere anche autodiretta. L’istanza del linguaggio come elemento di tenuta del gruppo può prevalere sul piano più dichiaratamente militante e non essere orientata apertamente alle parti sociali. Rimane una politica implicita o esplicita delle posizioni (dell’artista, dell’opera, del pubblico, dei contesti). I gruppi spesso esplorano la città più che mantenere uno spazio. La storia degli spazi coordinati da artisti e altri operatori s’incrocia ma non si sovrappone sempre esattamente a quella dei gruppi. Plurali sono gli obiettivi. Spazi come Zona non profit art space – caso significativo – sostengono ricerche performative, audiovisuali, concettuali, di expanded cinema, esoeditoria, etc., incoraggiando un dialogo importante per l’Italia con la scena internazionale, e questi sono gli obiettivi. Produzione culturale e dinamiche urbane si giocano la partita in vario modo in questa storia. Anche il leitmotiv dell’opposizione verso le istituzioni è da pensare fluidamente considerando sia l’effervescenza delle gallerie private che sperimentano nuovi linguaggi, sia le richieste di riforma degli enti stessi. Alcuni gruppi d’artisti auspicano d’avere rapporti programmatici con gli enti pubblici. La storia della Fabbrica di comunicazione a Milano e del Comitato Piazzetta a Sesto San Giovanni è esemplare in tal senso. Il sostegno della pubblica amministrazione è visto come opportunità per inserire la progettualità artistica nel quadro delle politiche di gestione territoriale. La “nuova committenza” di cui scrive Enrico Crispolti s’identifica anche con gli organi locali nell’ambito del decentramento amministrativo e con le istituzioni ricomposte democraticamente nell’intelaiatura del pensiero riformista del PCI[5] ma si rivela vicolo cieco. Da queste istanze politiche ed estetiche di un teatro storico affatto unitario si profila un desiderio problematico di autonomia prima che di autogestione, rimanendo tuttora una domanda di senso.

Café Müller a / at NESXT 2017
Note
[1] Carlo Cioni, in 1° Rassegna dei gruppi autogestiti in Italia, Studio d’arte Il Moro, Firenze 1980, pp. 16-17.
[2] Gian Franco Elia, Silvano D’Alto, Roberto Faenza, La partecipazione tradita, Sugarco, Milano 1977, p. 23.
[3] Michelangelo Pistoletto, Manifesto redatto in occasione della Biennale di Venezia del 1968.
[4] Laboratorio di comunicazione militante, Intervento n.1, convegno Arte e Società, Centro Internazionale di Brera, 12-22 novembre 1976.
[5] Enrico Crispolti, Arti visive e partecipazione sociale, De Donato, Bari 1977.