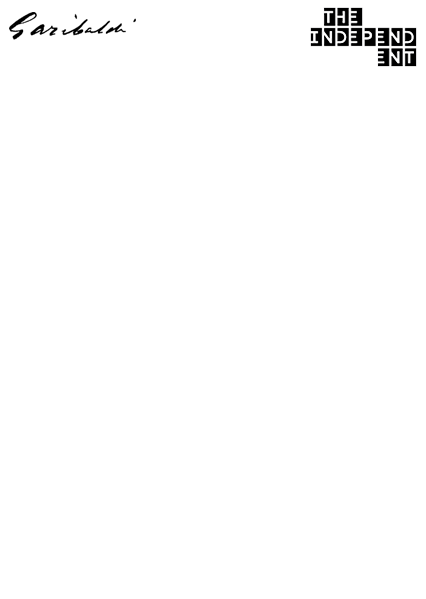
Gerundi
Cristiano Seganfreddo
“Tra questi frammenti di paesaggio nessuna somiglianza di forma. Un solo punto in comune: tutti costituiscono un territorio di rifugio per la diversità. Ovunque, altrove, questa è scacciata”.
Le parole del giardiniere filosofo viaggiatore Gilles Clément nel suo “Manifesto del terzo paesaggio” (quodlibet, 2005) introducono il tema della biodiversità necessaria allo sviluppo naturale. Senza biodiversità la natura impoverisce, indebolisce e perde di ricchezza. E il paesaggio diventa drammaticamente tutto uguale. Ad ogni latitudine e longitudine prolificano così solo le specie più resistenti e dunque gradite. Con conseguenza riduzione cromatica e tipologica dell’ambiente. Una metafora che legge anche il paesaggio culturale italiano, e non solo, governato spesso da istituzioni stanche e incapaci di leggere il presente. Una situazione diffusa in molte province, con conseguente incapacità di stabilire relazioni con una realtà globale e connessa. Abbiamo costruito territori chiusi e impermeabili, roccaforti di competenze e sicurezze progettuali. Spesso straordinarie nel passato, troppo spesso volontariamente conservatrici e burocratiche. Volenti o nolenti, bisogna aggiornare o cambiare i sistemi operativi, per un mondo che è straordinariamente diverso rispetto, a soli, 10 anni fa. E non è una questione di tipologia, (classico, moderno o contemporaneo; musei, gallerie o centri, regioni o stato), ma di atteggiamento. Di visioni. In soccorso sono emersi i segnali deboli e periferici del sistema, nel momento in cui il sistema è entrato in crisi. Il mondo “off” in Italia è molto vasto. Ha coloriture interessanti e variegate. È disomogeneo, imprevisto, spesso non rintracciabile. L’off patisce da sempre, è nella sua natura. Nomen omen. Non ha rappresentanza. Non si vede. Non esiste. È emarginato al ruolo di ancella progettuale a garanzia del localismo. Apparentemente non genera consenso, non produce economie sociali specifiche. Di conseguenza non ha peso politico. Reale come culturale. Il che significa capacità e capitale decisionale. Anche se è sostenuto o è emanazione di amministrazioni pubbliche, è sempre a rischio di estinzione e dunque di programmazione. Ha scarsa capacità di vedersi tra tre anni. Spesso anche soli tre mesi. Con un vantaggio. È molto resiliente. Combatte e si riproduce, cambia forma. Ma rimane.
Ai margini e nei bordi nascosti, tra le crepe del cemento delle strade, saltan fuori, nel disastro o nel deserto, piccoli episodi. Non vale la regola qualitativa ma quantitativa, qui. Cosa che farà inorridire qualcuno. È importante vedere che c’è un “sacco” di gente (Pierluigi Sacco è stato uno dei pochi, primi, veri game changer culturali anche in questo senso) che fa e si muove con una qualità media, alta. A volte anche molto bassa. Ma va bene così. Sono tantissimi esperimenti di persone che ipotecano tempo, in primis, eppoi scooter, pizza o bollette, per provare a inseguire marginali quanto centrali, tentativi di diffondere cultura contemporanea nelle loro comunità. O cultura, o frammenti, magari sconnessi. Sono riserve energetiche a varia grandezza.
Lo fanno ovunque, in modo insensato e sprovveduto. Senza regole, senza strategia, senza domani. Senza, forse, nemmeno rendersi conto delle fatiche e conseguenti delusioni, che arriveranno. Ci tentano, ci provano, forse ci vivono. Blog, spazi, residenze, azioni, attività, gallerie, coworking, sottoscala, occupazioni, capannoni, appartamenti, pubblicazioni, librerie, caffetterie…
Questi sono gli indipendenti. Ovunque. Li trovate nel profondo sud di Scicli come tra i capannoni di Arzignano nel vicentino, a Settimo Torinese, in Abruzzo quanto nel paesino campano.
Anche i nomi non vanno sottovalutati. Conservano la freschezza dei Flaiano: calembours, onomatopee, ossimori testimoniano la volontà di rompere la sequenza istituzionale dell’establishment.
Il gioco che ho pensato qualche anno fa, ormai sette, per ArtVerona, la prima fiera d’arte che ha dato spazio a tali progettualità, mirava a portare gli indipendenti ad essere evidenti e percepibili. Non per un processo di comunicazione o di classificazione anagrafica per un nuovo codice Istat, ma per evidente necessità culturale di muovere e smuovere i territori. Per generare qualcosa che fosse simile ad un naturale cortocircuito. E per aiutare gli indipendenti, dall’altra parte, ad uscire dalle piccole o grandi cortocircuitazioni autoreferenziali. Mettendoli assieme, in un luogo di mercato come una fiera.
Il tema era nell’aria. Da altre parti del mondo è ed era una normalità. Quasi un sistema integrato con il real estate alla Richard Florida.
Oggi gli indipendenti veri, e sono pochi, vanno aiutati a diventare le nuove istituzioni. Ad integrarsi con le istituzioni e a rigenerarle con uno sguardo connesso ed innovativo, ed un nuovo software. A fare open innovation culturale. Gli indipendenti sono come le startup per il mondo dell’impresa. Sono il futuro dell’economia. La naturale mortalità tra le startup, oltre il 90 per cento, genera comunque una economia forte e innovativa, se sostenuta da un sistema che ne capisce il potere rigenerante. Crescono competenze, network, diversità.
Dobbiamo sostenere i veri connettori della contemporaneità. Con l’obbligo formale di non ridurli ad esperimenti locali per l’ambizione di innovazione territoriale ma di metterli sempre in competizione con la piattaforma internazionale.

